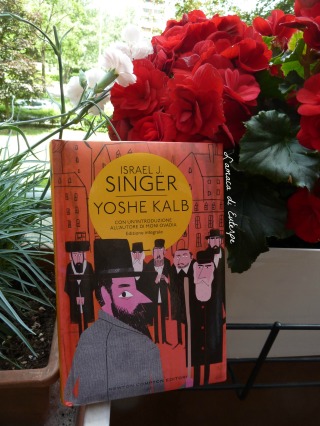Chi di voi/noi non ha visto da bambino/a la versione disneyana di questo racconto e non ha sognato di andare nell’isola che non c’è? Chi non ha sentito almeno una volta nella vita la versione cantata di Bennato (sì, qui lo so ho svelato un po’ di che epoca sono)? Chi non ha pensato almeno una volta ai pirati, mimando con le mani l’uncino di un famoso cattivo? Beh credo che ognuno di noi ha fatto questo e altro e si è sentito un eroe vero e proprio, come ho fatto io per lungo tempo.
Poi leggo il romanzo e qualcosa non quadra. Da sempre so che la Disney ha operato non tanto un rimaneggiamento del testo delle fiabe, ma una vera e propria riscrittura rendendo più appetibile ai piccoli storie ed emozioni, a fine benefico e positivo, creando così un falso mito (in senso di mitologia infantile) in tante generazioni; quindi era doveroso andare un po’ alla fonte delle cose e leggere gli originali (deformazione professionale oserei dire).
Mi armo di pazienza e inizio a immaginarmi di leggerlo a un piccolino, a voce alta (leggere a voce alta anche da soli è un buon esercizio di respirazione, attenzione, recitazione e concentrazione. Ve lo consiglio. E’ fondamentale, fidatevi), con quel senso che da sempre ritengo fondamentale di condivisione di saperi da una generazione all’altra. Eppure qualcosa non mi quadra…Peter è un bambino “caduto” come tanti altri, probabilmente dalla cesta o dal passeggino, senza che nessuno se ne sia accorto (ovviamente è la versione dal punto di vista di lui anche se non è biografico. Forse leggendo la versione della madre scopriremmo un destino ben più doloroso e purtroppo comune fino a 100 anni fa: la morte in culla), salvato dagli uccellini perché alla fine bambini e uccellini sono come una stessa stirpe. Il primo capitolo sembra un inno all’abbandonare le madri in quanto responsabili di far perdere l’uso delle ali ai propri piccoli: terribile!
Poi la storia procede come la conosciamo con Campanellino (fata dispettosa, femmina in tutto quello che è negativo, mai davvero fondamentale, gelosa e possessiva. Sì, alla fine davvero una fata!), Wendy, John, Michael, i bambini sperduti, Uncino, Spugna, la sua ciurma di pirati e il coccodrillo. Tutto è come te lo aspetti, non ci sono altri personaggi, ma è la loro descrizione, il loro agire che mi ha basita e un po’ terrorizzata.
Prima fra tutte Wendy: da subito ha un imprinting socio culturale fortissimo di “madre” e come tale si comporta in ogni suo momento con tutti, indifferentemente dal ruolo, persona o carattere. Lei gestisce, amministra, si strugge, controlla e si ritiene madre asessuata di quei piccoli, con un rapporto ambivalente e sul filo del morboso con Peter “padre” e “figlio” nello stesso momento. Al di là della differenza di caratteri fra me e Wendy e che sicuramente da bambina non l’avrei sopportata mezzo secondo, questo aspetto disturbante di “adolescenza precoce” (non parlerei di sesso, perché davvero significherebbe stravolgere tutto e anche malamente) mi ha infastidito rendendo il personaggio fuori luogo, odioso e purtroppo focale per il proseguimento della vicenda: Peter necessita di una madre per sè, per i bimbi sperduti, per la sua isola, per tutti, come un bisogno ossessivo.
Poi c’è Peter Pan che non ha nulla dello scanzonato ragazzino felice e divertente, ma invece mostra tutti i suoi lati oscuri di menefreghista, amorale (alla fine non la conosce), tutto incentrato su di sè e sui suoi bisogni, anche quando aiuta gli altri. Tutto deve girare attorno a lui e ai suoi voleri e tutti devono girargli attorno come unico capo indiscusso e incontrastato. Alla fine è un antieroe in grado di attirare le simpatie di tutte, ma di non tenere per sè niente altro che il tempo presente e le sue avventure. A leggere questo romanzo si capisce veramente meglio il fenomeno psicologico maschile che prende il suo nome…
E in ultimo, tralasciando tutti gli altri, c’è Capitan Uncino che svetta per essere un vero cattivo. Pur cercando di sminuirne la grandezza di pirata senza scrupoli con momenti da macchietta, tutta la sua descrizione (da quella fisica a quella psicologica) ruotano attorno alla parola carisma. Mi spiace Peter, ma per quanto tu sia il vincitore della storia, quello vero è questo pirata oscuro e da un passato (forse umano, ma non si capisce bene sta cosa) di grand uomo, vittima dei tuoi scherzi e dell’angoscia del coccodrillo, orgoglioso, attento alle buone maniere…insomma è davvero il pirata che ti aspetti dalla letteratura britannica.
Che altro dire? Che non sarei mai davvero in grado di leggerlo io a un bimbo perché non ne ho compreso il vero valore educativo, anzi per certi versi mi ha ricordato un po’ “Il signore delle mosche” di Golding, anzi un antefatto dove i bambini rifuggono qualsiasi regola sociale, se non quella di un leader capo indiscusso, e dove non c’è una vera libertà di azione e di autonomia. Forse alla fine quando i bambini sperduti faranno una determinata scelta di vita, c’è una visione pedagogica e moralizzante tipica del periodo in cui fu scritta, ma quella è l’unica azione personale (anche se di gruppo) che sbalordisce, se no tutti risultano succubi di Peter. Anche l’amore famigliare della famiglia di Wendy & co è molto macchiettistica e stucchevole e sinceramente non ho compreso nemmeno questo modo di descriverla (si salva Nana solo perché è tenera).
Voto: 6/7 Perché è ben scritto, ma mi ha terrorizzato. Tanto ci sarebbe da dire ancora di più, ma ne verrebbe fuori una tesi e questo non è il luogo.
Scheda tecnica
anno di pubblicazione: 1904
titolo originale: “Peter Pan in Kensington Garden”; “Peter and Wendy”
traduzione di Paolo Falcone
premessa di Diego de Silva
casa editrice Newton&Compton collana “I MiniMammut” n*85
finito di stampare marzo 2015 presso Puntoweb s.r.l., Ariccia (Roma)
copertina: illustrazione di © Mikel Casal
progetto grafico: Sebastiano Barcaroli
realizzazione: Alessandra Sabatini
pagine 224